A ottant’anni dal processo di Norimberga. Oltre l’alibi dell’obbedienza.
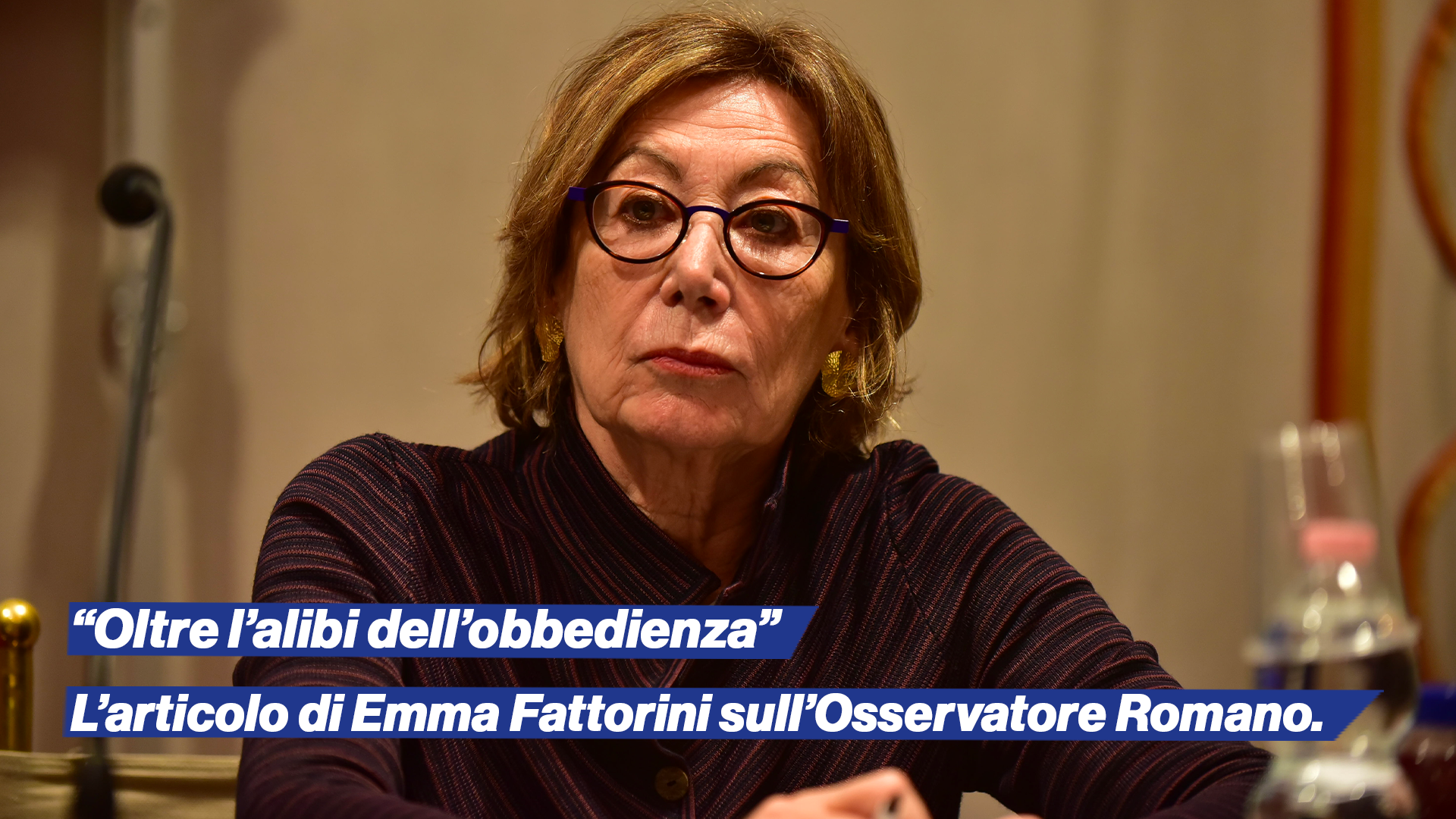
Il processo di Norimberga (20 novembre 1945) fu un discrimine. Fu quello, l'atto fondativo di concetti giuridici del tutto nuovi: crimini contro l'umanità, crimi di guerra, crimini contro la pace, responsabilità personale dei dirigenti politici e militari, anche se agiscono per obbedire allo Stato e ai superiori. Criminalità di apparato. Non esiste più l’alibi dell’obbedienza.
Già nella conferenza di Mosca del 1943 gli alleati si accordarono per rispedire i nazisti nei Paesi dove avevano perpetuato e commesso crimini localizzabili geograficamente, per essere giudicati dai tribunali dei Paesi dove erano state commesse. Ma il discrimine fu il processo di Norimberga su cui si accesero, fin da subito, le polemiche se fosse legittimo che i vincitori giudicassero i vinti, con spirito non equanime, o non «inconsciamente vendicativo», quando era ancora vivo il «rimorso» per le ritorsioni sproporzionate verso la Germania inferte dai vincitori della Prima guerra mondiale con il trattato di Versailles. E le atrocità, pur gravissime, «disumane», consentivano di scavalcare la sovranità dei singoli Stati? Infine, era giuridicamente legittima una condanna retroattiva di crimini inesistenti fino a quel momento? E che, come successe per le leggi della guerra sottomarina, erano crimini compiute anche dai vincitori?
Le immagini del processo fecero il giro del mondo, e restano impresse tra quelle le più significative del secolo scorso. E colpiscono davvero, a rivederle ancora oggi, quando si celebrano gli ottanta anni del processo di Norimberga. Quei filmati in bianco e nero, quasi completamente al maschile eccetto qualche sparuta traduttrice, quell’assembramento di uomini che si muove come una massa in movimento. Anche in questo raggiungendo espressioni inedite tra accusati e accusatori. Volti torvi, altri sbigottiti, quasi sorpresi più che spaventati, come a non capacitarsi. Come a non capire di cosa in fondo avrebbero dovuto essere accusati. Di avere fatto il proprio dovere? E poi di avere perso la guerra? Certo. Ma quante volte era successo nel corso dell’umanità? A che serviva un processo e poi nuovi diritti?
Il diritto più nuovo e in assoluto più carico di contenuto morale, perché tocca l’essenza dell’umano e dunque è universale e che diventa fondativo dei nuovi diritti, è quello che sancisce il crimine contro l’umanità. I criminali più efferati, come il ministro della propaganda Goebbels e il capo delle SS Himmler si suicidarono come Goering dopo l’accusa per evitare l’impiccagione.
Dieci mesi dopo il processo, le condanne non furono né esemplari e né numerose: dodici condanne a morte, tre all’ergastolo e quattro a lunghe detenzioni. Ma la potenza del messaggio su piano giuridico e simbolico fu potentissimo. I materiali delle stragi, delle sevizie, di quello che si sarebbe definito genocidio e già si configurava come un olocausto, scuotevano l’opinio- ne mondiale e lacerava, dall’interno, la società tedesca. E, del resto, le fonti su cui si basavano le condanne erano quelle naziste, non frutto di vendette dei vincitori.
Nel 1961, Hannah Arendt, fu invia- ta a Gerusalemme al processo Eichmann. Processo considerato uno degli effetti diretti di quello di Norimberga. Più disinteressata al piano giuridico, la studiosa si sofferma sul con- tenuto morale e politico degli individui passivi e consenzienti spettatori In Eichmann stesso, non vede un mostro ma un mediocre burocrate, amorfo e senza alcuna capacità empatica, indifferente ad alcun pensiero morale. E si concentra, come è noto, su come sia stato possibile che persone normali diventassero strumenti di genocidio, più che sul «male radicale e assoluto».
Arendt, rispetto alle accuse di Norimberga, si concentra piuttosto sulle responsabilità della passiva e indifferente burocrazia esecutiva. La sua è una critica implicita a Norimberga sul fatto di non personalizzare il male dei vertici senza vedere i milioni di esecutori. Insomma per Arendt il vero problema è la struttura che consente al male di diventare «normale». Dibattito che si sposterà, nei decenni a seguire, sul tema del «consenso» e/o indifferenza della popolazione verso i totalitarismi. Il suo pensiero, la sua «banalità del male», oggi ci interroga sulla indifferenza, disaffezione, e assuefazione rispetto alle guerre che ci circondano. Eppure, insieme, dobbiamo interrogarci con Arendt, su ciò che va oltre un solo giuridicismo. Per scavare nel più profondo possibile dell’animo umano, e delle coscienze. E perché i crimini contro l’umanità siano una soglia invalicabile. E al deteriorarsi della percezione del male. In primo luogo nelle coscienze. Che si riverbera nella disaffezione a fronte del progressivo dissolversi delle istituzioni politiche e giuridiche sovranazionali.
Da Norimberga in poi si sono con- formate le regole fondamentali del diritto internazionali che devono essere rispettate da tutti, che in varie tappe portò alla nascita della Corte penale internazionale.
La convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio del dicembre del ‘48, il processo di Norimberga, la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, e le quattro convenzioni di Ginevra del ‘49, venivano a costituire un blocco assolutamente nuovo dei diritti che diventava possibile per un accordo dei vari Stati che facevano parte delle Nazioni Unite.
Di ispirazione soprattutto americana l’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) fu creata nella conferenza di San Francisco (aprile-giugno 1945) in sostituzione della fallimentare Società delle nazioni, istituita il 28 aprile 1919, all’indomani della Prima guerra mondiale, durante i lavori della conferenza di Pace di Parigi, su proposta del presidente Wilson per assicurare la cooperazione, la pace e la sicurezza internazionale. Ben presto destituita di ogni autorevolezza.
Lo statuto dell’Onu eredita l’utopia democratica wilsoniana (i 14 punti), molto sentita nell’opinione pubblica americana e quella propriamente rooseveltiana sulla necessita di un «direttorio» delle grandi potenze come strumento di governo mondiale. Divenne via via uno specchio delle conflittualità internazionali con un eccesso del diritto di veto e una crescente perdita di peso, pur restando una importante tribuna mondiale.
E oggi? Assistiamo alla crisi degli organismi sovranazionali e delle corti penali. Sono delegittimati dalle stesse nazioni che li hanno promossi. I “grandi imperi” contemporanei intorno a cui si aggregano e si smontano le alleanze. E dunque siamo sgomenti nel vedere indebolirsi fino allo svuotamento gli istituti sovranazionali proprio nel momento in cui ne avremmo più bisogno. Ed evidentemente accade proprio per quello, in una spirale sempre più pericolosa. Processo che oggi sembra inarrestabile. Lo ha denunciato nel giugno scorso anche Leone XIV: «È veramente triste assistere oggi in tanti contesti all’imp orsi della legge del più forte, in base alla quale si legittimano i propri interessi. È desolante vedere che la forza del diritto internazionale e del diritto umanitario non sembra più obbligare, sostituita dal presunto diritto di obbligare gli altri con la forza. Questo è indegno dell’uomo, è vergognoso per l’umanità e per i responsabili delle nazioni».
È dunque necessario indagare le cause e le ragioni senza moralismi e velleitarismi. Con realismo e pragmatismo. È recentemente uscito un piccolo, acuto libro, Caos. La giustizia internazionale sotto attacco (Laterza, 2025) scritto da Marcello Flores, lo storico più autorevole su questi temi, ed Emanuela Fronza, brillante studiosa di Diritto penale internazionale. Gli autori si interrogano sul perché «queste istituzioni sono sotto attacco: i tribunali sono delegittimati, non vi è cooperazione per giudicare chi si macchia di crimini efferati. Cos’è che non funziona? Perché Russia, Israele e Stati Uniti contestano la legittimità di queste corti? Perché molti Stati non si attiva- no per farle rispettare fomentando il caos? Dobbiamo relegare l’idea stessa di una giustizia internazionale a utopia senza futuro?».
Ci si può chiedere, di fronte a questa spirale in caduta libera, cosa può fare la diplomazia vaticana, “organismo” a suo modo sovranazionale. Come più volte già a suo tempo sottolineato da Papa Francesco, di fronte all’infinita guerra ucraino-russa, andrebbe recuperato lo spirito che animò le risoluzioni di Helsinki del 1975 in cui tanta parte ebbe l’intervento della diplomazia della Santa Sede.
Di Emma Fattorini, sull'Osservatore Romano.

